La casa dei nonni può essere assegnata ai genitori che si separano?
«Avvocato, mia moglie e io stiamo affrontando la separazione, ma la casa in cui viviamo è di proprietà dei miei genitori. Con i bambini piccoli non so come potrebbe funzionare: può il giudice assegnare la casa familiare anche se non ce l’abbiamo in proprietà?»
«Buonasera, questa è una domanda più frequente di quanto si pensi e che merita attenzione. Il diritto di famiglia assegna grande rilievo alla tutela dei figli e alla loro stabilità abitativa, ma il caso in cui la casa non è di proprietà diretta dei genitori apre scenari complessi, che la giurisprudenza ha affrontato con articolazioni importanti.»
Partiamo da un dato certo: l’articolo 337-sexies del Codice civile detta la regola per l’assegnazione della casa familiare, contemplando il principio che, nei procedimenti di separazione o divorzio, il godimento della casa deve essere “attribuito prioritariamente tenendo conto dell’interesse dei figli minori o non autosufficienti”.
Il criterio fondamentale, dunque, resta proteggere la continuità ambientale e affettiva della prole, riconoscendo che la casa rappresenta il fulcro della loro stabilità.
La complessità quando la casa è proprietà dei nonni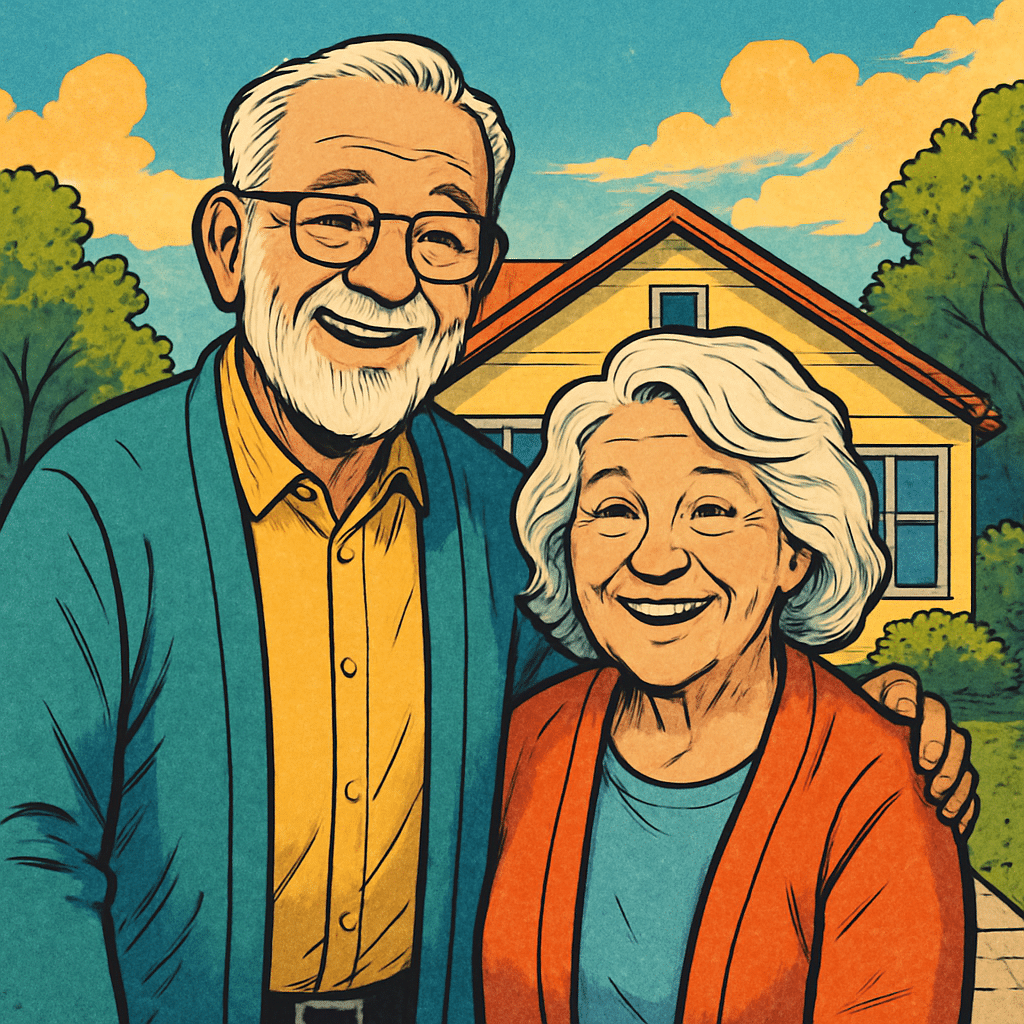
Nel caso in cui l’abitazione sia di proprietà dei nonni, la situazione non è così semplice. Il giudice, infatti, non può attribuire un diritto di proprietà o di godimento che non sussiste, e deve bilanciare la tutela dei figli con il rispetto della proprietà privata del terzo.
La Corte di Cassazione ha, dunque, ribadito da tempo che: «l’assegnazione della casa familiare non può mai configurarsi come una creazione ex novo di diritti reali in capo al coniuge non proprietario, se ciò comporta un sacrificio ingiustificato per il titolare del diritto di proprietà». In sostanza, il giudice non può ignorare il diritto del terzo proprietario a riprendere il possesso.
Il comodato d’uso come strumento di tutela temporanea
Spesso, come nel caso affrontato recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 17095/2025, la casa dei nonni è affidata ai coniugi tramite un comodato d’uso gratuito finalizzato a garantire residenza stabile alla famiglia e, soprattutto, ai bambini.
La Corte ha osservato che in questi casi, con l’interruzione della convivenza, i genitori collocatari e i figli minori hanno «diritto al godimento dell’immobile concesso», purché questo risponda a un concreto interesse superiore della prole. La sentenza precisa che: «L’assegnazione della casa familiare concessa in comodato d’uso da terzi trova fondamento nel principio di tutela della continuità abitativa della prole, e può prevalere sul diritto di recesso del comodante, solo se strettamente necessario a salvaguardare gli interessi dei minori.»
Bilanciamento tra diritti del proprietario e interesse dei figli
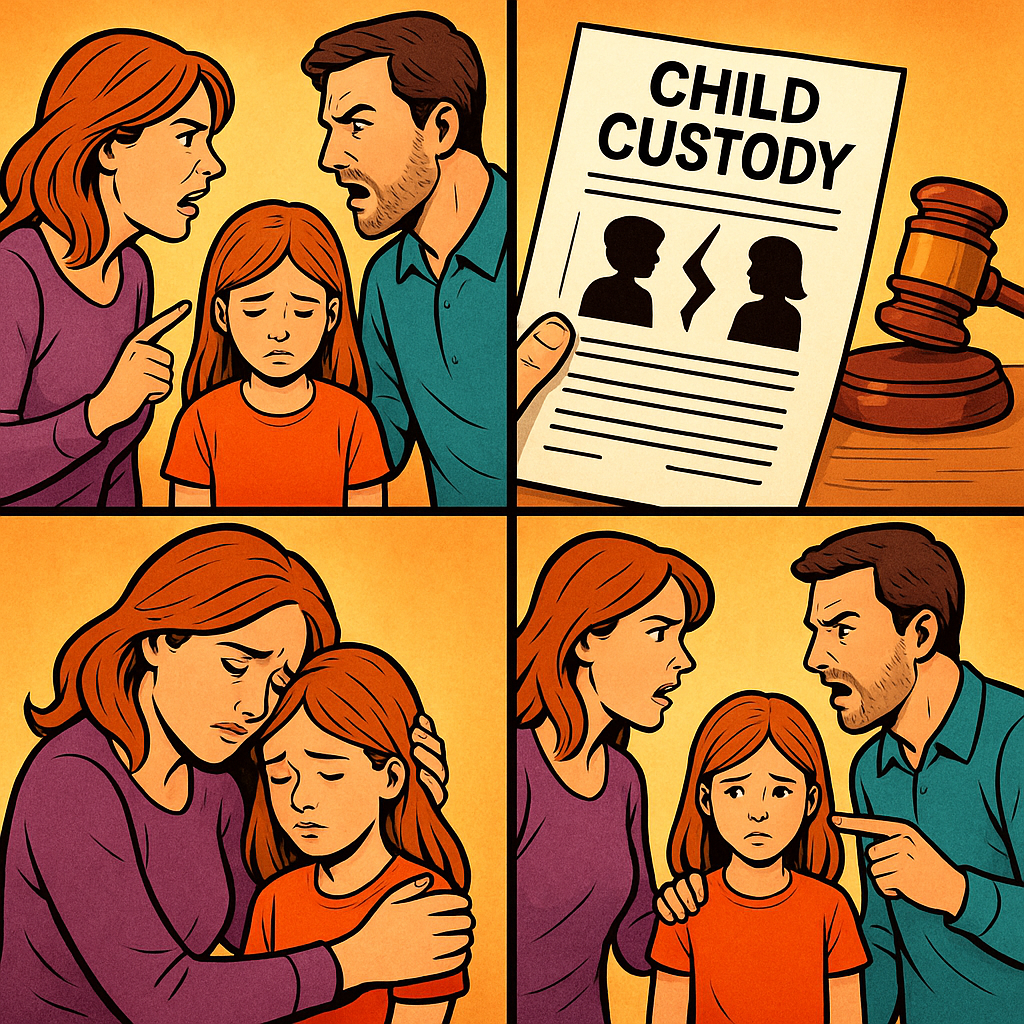 Tuttavia, tale situazione deve essere valutata con equilibrio. Il proprietario conservando il diritto di chiedere la restituzione del bene, ha diritto a una tutela giuridica che però non può prevalere in modo assoluto sull’interesse dei bambini a mantenere l’ambiente familiare stabile e sicuro.
Tuttavia, tale situazione deve essere valutata con equilibrio. Il proprietario conservando il diritto di chiedere la restituzione del bene, ha diritto a una tutela giuridica che però non può prevalere in modo assoluto sull’interesse dei bambini a mantenere l’ambiente familiare stabile e sicuro.
Il giudice, quindi, è chiamato a ponderare caso per caso, tenendo conto di:
- La concreta situazione abitativa e relazionale della famiglia prima della separazione;
- La possibilità del terzo proprietario di recuperare l’immobile senza ledere l’interesse dei figli;
- Soluzioni di compromesso come il rilascio dilazionato nel tempo o la ricerca di un’abitazione alternativa;
- La necessità di evitare discontinuità traumatiche nella vita dei minori.
Dal punto di vista pratico, per gli avvocati è fondamentale ricostruire con precisione i rapporti contrattuali o negoziali tra i genitori e il terzo proprietario, valutando se esistano comodati scritti o accordi effettivi. È altresì utile anche raccogliere testimonianze e documentazione sul fatto che la casa sia stata da sempre adibita a residenza stabile e che la sua perdita comporterebbe un grave danno per il minore, anche a livello affettivo e sociale.
