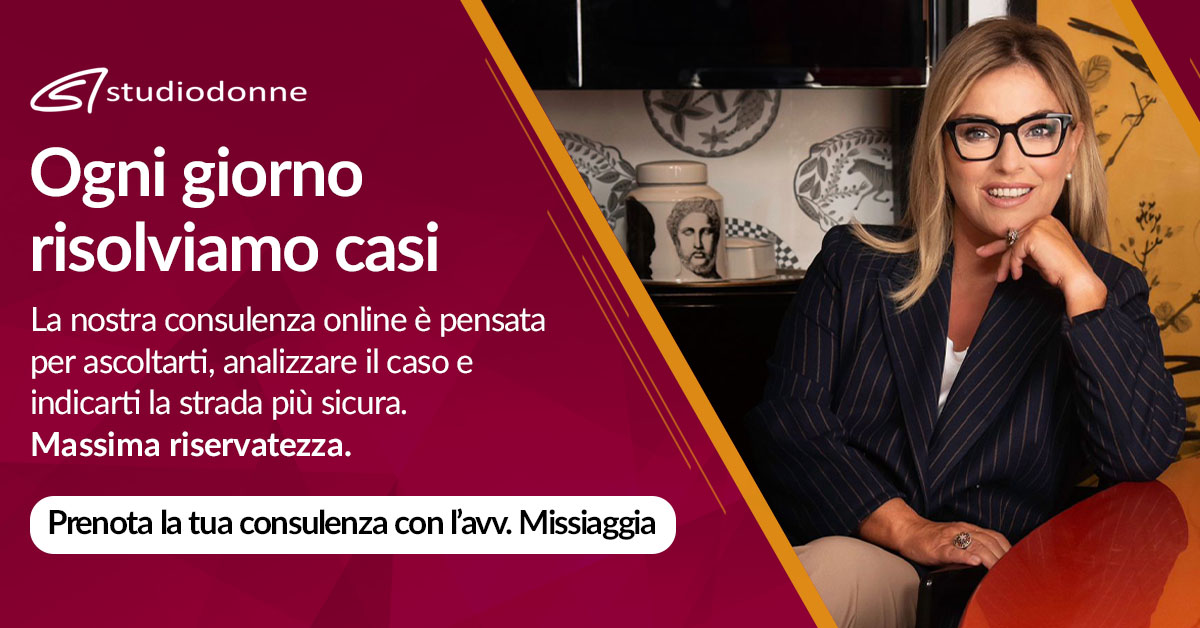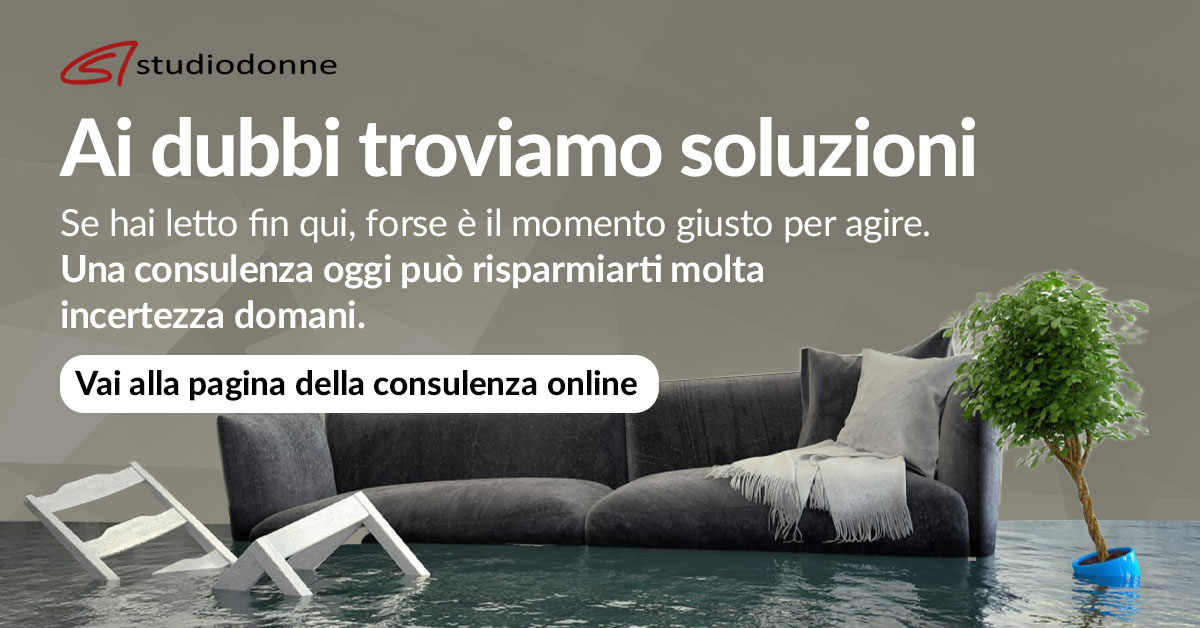«Avvocato, ma se un marito rinuncia alla propria carriera per dedicarsi alla gestione dei beni familiari, può poi pretendere un assegno divorzile?».
«Dipende. La giurisprudenza, oggi, tende a valutare il contributo alla vita familiare anche al di là dei ruoli tradizionali. La recente Cassazione del settembre 2025 ne offre un esempio emblematico».
Oltre il paradigma del coniuge “debole”
La pronuncia della Cassazione, Sez. I Civ., Ord. 18 settembre 2025, n. 25556, affronta proprio questa questione delicata: può l’ex marito, che aveva abbandonato un impiego stabile per amministrare i rilevanti beni della moglie imprenditrice, chiedere un assegno divorzile dopo la fine del matrimonio?
Il tema si colloca tra la funzione compensativa dell’assegno e la parità sostanziale dei coniugi, ormai scolpita non solo nell’articolo 29 della Costituzione ma anche nell’art. 143 del codice civile, che impone collaborazione e contribuzione proporzionata alle capacità di ciascuno.
La Cassazione conferma che l’assegno divorzile non ha soltanto natura assistenziale, ma anche, e soprattutto, compensativo-perequativa. Nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, si è chiarito che l’assegno mira a riequilibrare gli effetti economici del matrimonio, riconoscendo il contributo fornito dal coniuge che, di fatto, ha sacrificato opportunità professionali per la famiglia.
Il caso concreto e la pronuncia della Corte
Nel caso deciso con l’ordinanza n. 25556/2025, il marito aveva lasciato il lavoro per occuparsi della gestione del consistente patrimonio immobiliare e societario intestato alla moglie. Al momento del divorzio, egli si trovava privo di reddito stabile, mentre la donna aveva consolidato la propria posizione economica.
Il giudice di merito aveva negato ogni forma di assegno, ritenendo che il marito avesse agito per interesse personale. Ma la Cassazione ha ribaltato tale impostazione, richiamando il principio di “solidarietà post-coniugale”, sottolineando che non può penalizzarsi chi, nell’ambito del matrimonio, ha svolto un’attività di supporto gestionale o familiare in favore dell’altro coniuge.
Scrive la Corte: «Il contributo non deve misurarsi soltanto in termini di reddito o sacrificio economico, ma anche in termini di cooperazione funzionale e gestionale al progetto familiare».
In altre parole, anche se il marito non ha generato un reddito proprio, egli ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio familiare e, dunque, al benessere comune. Quel contributo, pur non monetizzabile in senso stretto, assume rilievo quando la crisi coniugale determina un evidente squilibrio patrimoniale.
Quali sono le implicazioni pratiche di una pronuncia del genere?
È fondamentale stabilire che non è sufficiente dimostrare la semplice disparità economica tra i coniugi: occorre provare che la rinuncia del marito a un’attività propria sia stata funzionale al progetto familiare condiviso.
A tal fine, assumono rilievo documenti, comunicazioni o testimonianze che attestino il ruolo concreto svolto nella gestione dei beni comuni o della controparte.
Bilanciare libertà e solidarietà
La Cassazione, pur senza dichiararlo espressamente, richiama il principio di “reciprocità contributiva”: la libertà economica di ciascun coniuge non può mai trasformarsi in vantaggio esclusivo di uno solo.
L’assegno divorzile, in questa prospettiva, diviene un presidio di equità redistributiva, capace di restituire equilibrio a relazioni in cui le scelte di vita hanno generato asimmetrie patrimoniali che prima della separazione non venivano in risalto.
Una riflessione conclusiva
Questa decisione spinge verso un’idea sostanziale di giustizia familiare: non si tutela l’inattività, ma si riconosce il valore del lavoro non retribuito che sostiene la vita comune.
In questo senso, la Cassazione n. 25556/2025 riafferma che il matrimonio è un investimento reciproco, e il divorzio non può azzerarne la memoria economica.